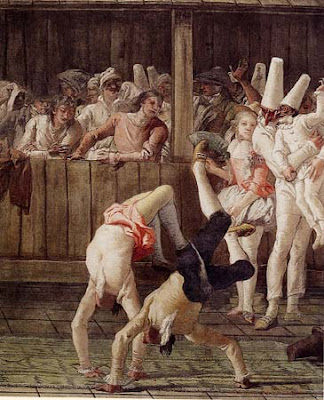E’ una piacevole sorpresa l’ultimo articolo di Vittorio Gregotti sul Corriere della Sera, Le ipocrisie verdi delle archistar.
Prima di tutto per lo stile con cui è scritto, ironico, direi beffardo, molto chiaro e diretto, contrariamente al suo modo consueto di scrivere piuttosto involuto e criptico. Ha tenuto, sì, a far sapere di conoscere Heidegger, ma per fortuna ha avuto il buon gusto di risparmiarcelo. Si vede proprio che questa volta aveva da dire qualcosa di veramente importante che gli usciva dai denti.
Intanto prendiamo atto che oggi dare dell’archistar ad un architetto è diventata quasi un’offesa. Se fosse vero anche in piccola parte, e probabilmente è vero, non sarebbe tanto importante lo svilimento dell’appellativo in sé quanto dei suoi presupposti, cioè del fatto che l’atteggiamento da profeti non solo dell’architettura ma anche della società, dei suoi costumi e perfino della sua economia (vedi il falso “effetto Bilbao”) vacillerebbe non poco. E sarebbe l’ora che gli architetti tornassero a fare gli architetti, almeno quelli che possono, e non i falsi profeti e/o i portavoce dei grandi gruppi editoriali, finanziari e di potere. E sarebbe anche l’ora che tornassero a farlo meglio il loro mestiere, progettando per la città e per se stessi e non per se stessi e basta.
Gregotti, in fondo, nel suo articolo dice esattamente questo, ironizzando sul lato modaiolo eco-bio-compatibile-sostenibile dell’architettura spettacolo ma anche di quella più comune, cui quella spettacolo fa ovviamente da trailer e da spot pubblicitario.
Che dire, ad esempio, delle case prefabbricate in legno, di chiara origine nordica e trentina, che adesso sembra vadano bene per il caldo, per il freddo, per il terremoto e perfino per il paesaggio italiano? Non è forse un sistema smaccatamente lobbistico di far passare un prodotto che andrà bene in Trentino ma che per certo nel 95% del territorio antropizzato italiano è roba da baracche provvisorie o da giardino?
Gregotti colpisce la punta dell’iceberg, quella visibile. Colpisce la banalità del bosco verticale con la parabola della sua vecchia zia (davvero un Gregotti così spiritoso e familiare è sorprendente), o dell’EXPO 2015 che salverà il mondo dalla fame probabilmente con una bella operazione edilizia a fine esposizione.
I suoi strali si appuntano sull’architetto Boeri, per concludere con una puntatina su Rem Koolhaas, ma molti altri, noti e meno noti, potrebbero essere al centro della sua attenzione. Non c’è infatti progetto che non venga veicolato e decantato per le sue qualità di sostenibilità ambientale; per i grattacieli in specie - la tipologia più anti-ecologica, consumistica, energivora (oltre che anti-urbana) che l’uomo abbia mai inventato – la prima cosa che viene detta, quasi a mettere le mani avanti, è che sarebbero sostenibili, autosufficienti, addirittura, e amenità del genere.
Capisco che è un articolo di giornale, per cui Gregotti ha dovuto sintetizzare alcuni concetti, e l’ha fatto egregiamente, però non sarebbe male che, magari in un futuro, appuntasse la sua attenzione sulla vera e unica sostenibilità dell’architettura e dell’urbanistica, e cioè quella che si ottiene con un progetto che non sprechi territorio libero, che non tema la densità edilizia e non chieda come in un mantra “il verde” per giudicare la qualità di un insediamento, che densifichi gli insediamenti esistenti realizzati nella logica dei lotti senza relazione tra loro e con la strada, anzi senza strada, che utilizzi materiali tradizionali e il più possibile locali, con il doppio vantaggio di risparmiare nei trasporti e di costruire in armonia con la tradizione dei luoghi.
Non basta ironizzare sull’ambientalismo lobbistico e bugiardo, ma un architetto del calibro di Gregotti dovrebbe inquadrare il problema con una visione più ampia e proporre una alternativa ad un problema reale, quello dei consumi e dei costi energetici, proprio in questi giorni tornati di grande attualità.
Una città compatta e fortemente costruita, dove il pieno prevalga sul vuoto, con tutte le funzioni presenti e mescolate, gerarchizzate in senso verticale e non separate in senso orizzontale, riduce fortemente la necessità di trasporti meccanici, non solo, e forse non tanto, per gli spostamenti casa-lavoro, quanto per tutte le altre innumerevoli quotidiane attività urbane che, viceversa, in una città diffusa e divisa in aree funzionalmente omogenee costringono all’uso continuo dell’auto: accompagnare i figli a scuola, fare la spesa, spostarsi da un ufficio all’altro, andare dal dentista, pagare l’assicurazione, andare in banca o alla posta o in palestra, perfino a fare due passi per incontrare qualcuno.
Certamente in una grande città metropolitana i problemi si pongono in maniera più problematica e perfino drammatica, e il sistema della mobilità è più complesso e richiede un forte intervento di infrastrutture pubbliche, ma è assurdo ed insensato, una vera vergogna dell’urbanistica ortodossa, come la chiama Jane Jacobs, che nella stragrande maggioranza dei piccoli e medi centri urbani di cui è composta l’Italia ci si debba trovare nelle medesime condizioni delle aree metropolitane.
In queste realtà è possibile e indispensabile proporre e agire di conseguenza. Ritornare alla città, una bella frase, un concetto tutto sommato semplice da comprendere, è l’unica soluzione possibile. Ma è così semplice, almeno concettualmente, che evidentemente viene ritenuto non adatto alla complessità delle soluzioni che deve proporre un architetto, visto che tutto continua ad andare nella direzione opposta. Tutto continua come prima, con rigide zonizzazioni e classificazioni di aree, addirittura di edifici, per funzioni, l’attenzione è puntata sempre sulla funzione, sul “cosa collocare in quel luogo”, con una occhiuta, illiberale e dirigistica velleità di decidere non solo "ciò che" ma anche "dove" serve alla società. Se lasciassero decidere alla legge del mercato, alla libera iniziativa, questa saprebbe esattamente ciò che serve, e quindi rende, e ciò che è superfluo, e quindi è improduttivo.
Eppure la risposta dovrebbe essere una sola: un pezzo di città!
Invece si producono rigide classificazioni, norme sulle distanze che impediscono ogni intasamento dei lotti e ogni ristrutturazione urbanistica che ridisegni intere aree delle periferie, l’attenzione "eco" puntata sempre e comunque sul singolo manufatto, sull’oggetto, sulle soluzioni tecnologiche, senza uno sguardo all’insieme, al disegno della città, l’unico che può garantire soluzioni di lunga durata e una vita urbana a misura del pedone.
C’è una straordinaria relazione tra riduzione dei consumi energetici e miglioramento della qualità della nostra vita urbana: per soddisfare la prima occorre lavorare sulla seconda.
Ecco, nei prossimo articoli di Gregotti ci aspettiamo una indicazione in tal senso: meno attenzione agli oggetti e all’architettura e più all’insieme e alla città, la vera emergenza per la cultura degli architetti.
28 febbraio 2011
GREGOTTI E LE VERDI ARCHISTAR
24 febbraio 2011
PASSATISMO CONTRO MODERNO-NON-MODERNO
Questo post è in stretta relazione con il suo omonimo nel blog Archiwatch di Giorgio Muratore, scritto da Giancarlo Galassi, allievo di Gianfranco Caniggia, e alla sua lettura rimanda per una comprensione dell'argomento. Avverto che per leggere l'originario post è necessario scaricare un file di word.
Quello che segue è il commento, che io ritengo conclusivo dell'argomento, non una volta per tutte ma certamente in ordine alle argomentazioni oggetto del post stesso e di alcuni suoi commenti, scritto da memmo54 che mi ha autorizzato a pubblicarlo. Ringrazio anche Giorgio Muratore, a cui non ho chiesto il permesso, ma ho presunto che me lo avrebbe dato e comunque sono certo che non mi denuncerà per questo.
L'argomento è la proposta di ricostruzione di parte di un isolato in Via Giulia, a Roma, e nasce da un numero speciale de Il Covile a questo dedicato e che invito a scaricare e leggere.
Le premesse sono sinteticamente queste:
-il prof. Paolo Marconi viene invitato dal Comune di Roma a presentare una proposta metodologica di ricostruzione per l'area di Via Giulia;
- Marconi risponde con una ricostruzione filologica;
- il progetto non è condiviso dall'ufficio del centro storico e Alemanno invita sette architetti più o meno famosi a presentare altre proposte;
- tutti e sette gli architetti rifiutano il restauro filologico e presentano progetti "contemporanei";
- nel frattempo, però, gli studenti dell'Università di Notre Dame, guidati dal prof. Ettore Maria Mazzola avevano da tempo studiato l'area, producendo alcune soluzioni redatte da gruppi di studenti;
- il Sindaco decide di far scegliere i cittadini, limitando però la scelta solo ai progetti dei sette architetti "moderni" e non quello del prof. Marconi, tanto meno quello della Notre Dame.
Da questa palese manifestazione di pensiero unico nasce il numero de Il Covile e il conseguente post di Giancarlo Galassi su Archwtach.
Non voglio ripetere la mia ammirazione per il testo di memmo54, già espressa su Archiwatch, per non farla troppo lunga.
Il commento di memmo54:
Del sito conosciamo benissimo quanto demolito; meno bene le case romane che v’erano sotto. Non sappiamo se fossero domus, insulae o cos’altro. Lanciani non me ne da notizia: riporta solo alcuni tratti di strada romana su vicolo del Malpasso.
Dovendo procedere ad un progetto e/o restauro, sinonimi anche nel nostro caso, e nell’incertezza forse è più utile raccogliere le indicazioni, attendibili, più recenti : potrebbe anche essere una rifusione matura di celle primitive.
Comunque quanto demolito aveva senso compiuto ed era in sintonia con tutto il costruito dei pochi millenni trascorsi. Credo, sinceramente, che tutti l’abbiano ben presente.
Lo era per tipologia o derivazione tipologica; per tecniche, per materiali e per quel linguaggio epidermico, con cui confrontarsi inevitabilmente, che turba i sonni, lo sospetto, a più di un addetto ai lavori.
La tipologia, nel senso più esteso, è sicuramente una chiave di lettura ineludibile. Ma pur sempre “una” lettura e sarebbe riduttivo ed ingenuo derivarne tutto il progetto, a meno che una schiera di scatoloni di vetro o cls posti a schiera possano essere gabellati per romani purchè abbiano volumi e bucature al posto giusto.
La tradizione, nel suo fenomeno più radicale qui denominato passatismo, è comunque cosa complessa.
Così come complessi sono anche i materiali, le tecniche, il linguaggio: presi da soli non risolvono alcunchè non mettono al riparo da nulla.
Però quelle mostre quelle cornici quel bugnato, quei tetti, quei colori che tanto disturbano, sono parte integrante, dell’architettura e dell’universo; forse la più significativa ed immediata, la più leggibile, anche se non sempre calata nella situazione opportuna. Rimangono strumento insostituibile di comunicazione tra uomini ed architetture che sembrano, a prima vista, ignorarci ed ignorarsi.
Lo sono anche a dispetto della rigorosità e della coerenza con quanto “preordinato” strutturalmente o tipologicamente; così che in molte espressioni “genuine”, l’apparato linguistico di superficie travalica la semplicità insita, ponendosi come “sostanza” esso stesso.
Tutti concetti ovvi, banalissimi che sembra pleonastico rimarcare…ma tant’è …repetita juvant.
D’altronde il linguaggio, di qualsiasi genere lo si intenda, è “comunque” un copia ed incolla (…come si dice ora…): è, inevitabilmente, una ripetizione di esperienze passate, attimi di vita trascorsi, sedimento di generazioni e generazioni di architetti invisibili, scomparsi, sepolti: da cui dedurre, senza allontanarsi molto dal vero, che il tempo è il peggiore degli inganni; non è mai passato veramente.
Però 80 anni di civiltà industriale, ora in declino e prossima allontanarsi da questi lidi, hanno creato il deserto, nel cuore degli architetti, strappandoli dal naturale contesto, dalla vita, per consegnarli indifesi e soli a sbrigarsela ognuno col suo peccato, ad affaticarsi su indimostrabili miti, su approcci tecnico-scientifici volubili ed evanescenti, “insostenibili” sotto tutti i punti di vista.
Saremo costretti – malgrado noi, par di capire – a risperimentare il nostro passato dopo averlo superficialmente superato e dimenticato in questa febbre e frenetica incoscienza da divinità in delirio.
Il recupero potrebbe essere per molto tempo un aborto, una mescolanza infelice tra nuove comodità ed antiche miserie.
Ma ben venga anche questo modo confuso e caotico questo “passatismo”.
Tutto è meglio del tipo di architettura e di vita che la modernità impone.
Saluto
memmo54
13 febbraio 2011
LETTERA A MASSIMILIANO FUKSAS
Quella che segue è una lettera aperta a Massimiliano Fuksas, quasi lo conoscessi, anzi, quasi fossimo amici. La forma epistolare è solo un espediente retorico che dovrebbe rendere più immediata e digeribile l’esposizione di qualche pensiero. Non lo conosco invece, e dunque non posso essere suo amico, né potrei esserlo, credo, anche se lo conoscessi. Non certo per la diversa collocazione politica, che questa non mi è affatto di ostacolo con altri amici reali, e neppure per l’oggettivo abisso professionale che ci separa, che anzi io sono sempre affascinato da chi è riuscito a raggiungere il successo, essendo convinto che questo è il frutto di una forte componente di merito individuale, in dosi variabili da caso a caso, naturalmente, ma per aspetti squisitamente caratteriali, almeno da quel poco che ho potuto intuire dai suoi interventi televisivi e giornalistici.
Diciamo che certi suoi atteggiamenti un po' ribaldi, pur risultando talora anche divertenti nella loro estemporaneità e (apparente?) genuinità, quella sua ingenua sicurezza di rappresentare sempre la parte giusta, l’unica naturalmente, confliggono con la mia timidezza nei rapporti personali che mi impedirebbe di mettermi al centro del mondo. Forse è anche la sua imponente figura da austero busto di antico romano ad accentuare una sua certa (apparente?) prosopopea, stemperata, per fortuna, dal forte contrasto con non rare sue iperboliche e improbabili affermazioni apodittiche (famosa quella su Cicerone, cui indubbiamente assomiglia), che contribuisce ad umanizzarlo e a renderlo simpatico.
Avrei potuto recentemente confermare queste mie impressioni andandolo ad ascoltare, e vedere, di persona ad Arezzo, essendo egli intervenuto alla presentazione di un suo libro, che ahimè non ho letto, ma si sarebbe svolta di sabato alle 21,00 e non me la sono sentita di rinunciare ad una tranquilla cena tra amici e di costringermi ad ingoiare qualcosa di corsa, come si fosse trattato di un giorno di lavoro qualsiasi. Alla prossima occasione.
*****
Caro Max
Ho letto su L’Espresso di questa settimana un tuo articolo dal titolo: “Dimenticare Bilbao”. Già dal titolo ho istintivamente peccato di vanità, lo ammetto, masticando tra me e me: “Mi hai fregato l’idea. Hai letto il mio post e te ne sei appropriato. Almeno, da amico, avresti potuto citarmi. Una citazione fatta da te mi avrebbe lusingato assai. Avresti potuto fare un piccolo accenno al fatto che ne abbiamo parlato insieme più volte, se proprio non volevi nominare il blog che, effettivamente, non è proprio schierato dalla tua parte”. E’ seguita una espressione a denti stretti che tralascio di scrivere per educazione.
Leggendolo per intero, poi, quella prima impressione si è anche irrobustita, perché l’articolo parlava anche d’altro e l’effetto Bilbao non è che ci azzeccasse molto, espressione questa cara ad un tuo amico che però non ci è comune, e della quale amicizia io non sono mai stato geloso.
Forse non è proprio esatto dire che non ci azzeccasse, direi che non mi è risultato chiaro se volevi parlare della fine dell’effetto Bilbao, e hai colto l’occasione di farlo con un progetto di Gehry che io non conosco, e del quale tu sembri apprezzare una certa, nuova e insolita sobrietà, oppure se volevi solo parlare del progetto di Gehry e ci hai infilato en passant la fine dell’effetto Bilbao perché l’avevi appena letto sul blog e non volevi perdere l’occasione per andare in testa al gruppo, come si conviene ad un campione.
Ripensandoci, poi, ho capito che era solo la mia immodestia ad avermi fatto immaginare una cosa del genere, e che tu non hai certo il tempo di spippolare troppo in internet, tanto meno di perderlo con il mio blog del quale conosci l’esistenza, perché te l’ho detto qualche volta, ma non sono affatto sicuro che tu lo abbia mai aperto.
Certamente tu sei sempre in giro per il mondo a seguire i tuoi progetti e penso che durante i viaggi tu sia indaffarato a riguardare relazioni, preparare gli incontri, documentarti sugli stati di avanzamento, ecc. Al più, in aereo, puoi prendere ispirazioni dall’oblò per una nuova nuvola, o puoi schizzare qualcosa di nuovo su un libriccino di appunti, nei rari momenti di relax!
Quindi, capitolo chiuso e, trascurando improduttive e stucchevoli questioni di primazia, resta il fatto che tu accogli con soddisfazione la dichiarazione della fine di questo effetto, se mai c’è stato veramente, e, soprattutto, la proliferazione dei tanti piccoli “effetti Bilbao” su tutto il territorio nazionale. Vorrei farti osservare che ad alimentare questo stato di cose hai contribuito, e non poco, anche te, magari inconsapevolmente, che non vuol dire incolpevolmente!
Vi hai contribuito con la tua architettura, che non è che tenda proprio a mimetizzarsi e a non farsi notare, che, insomma, parla di nuvole, mica di fondazioni e di muri e di tetti, che racconta di grattacieli sul mare capaci di riqualificare tutta un’area di Savona, che disegna la città viola che mette al centro del programma non dico lo stadio, ma addirittura l’etica del calcio e l’indottrinamento, pardon, l’educazione di giovani ed adulti ad una sana visone sportiva. Magari questa forma di città etica, terribilmente autoritaria nella sua concezione, non è nelle tue intenzioni, magari è solo uno spot pubblicitario del Presidente onorario che tra l’altro ha detto: “Io mi aspetto uno stadio comodo, fresco d’estate, caldo d’inverno, dove le famiglie possano trascorrere giornate intere. Io purtroppo non ci sono spesso ma Andrea mi dice che in Europa ci sono impianti di grandissimo valore“.
T’immagini una città del calcio dove le famiglie possano trascorrere intere giornate! E’ questa la tua visione di società e di città e del modo di trascorrere il tempo dei suoi abitanti? Io credo di no, però il tuo marchio su questa idea di città-spettacolo ci sarebbe. Ma il Presidente onorario aggiunge anche dell’altro: “Non esiste niente del genere nel mondo- dice il patron viola- e ancora museo d’arte contemporanea sulla scia dello splendido Guggenheim di Bilbao, hotel delle maggiori catene alberghiere, una strada aperta ai negozianti di Firenze, aree verdi, parcheggi. Investimenti previsti: 150 milioni di euro per lo stadio, 250 per il resto”. Come vedi l’effetto Bilbao è evocato e utilizzato a piene mani.
Insomma, tu sei una riconosciuta archistar, direi anzi che sei la vera e unica archistar italiana, dato che Renzo ha, a questo punto, superato quella fase per passare direttamente e senza processo alla beatificazione per acclamazione.
Quello che fai e dici te si riverbera su una infinità di architetti che ti imitano, che assumono il tuo modo di pensare l’architettura e la città. Questa è la responsabilità che ti deriva dall’essere architetto di grande successo. Tu hai, oggettivamente, obblighi di coerenza maggiore degli altri, maggiori di tutti noi, perché sei un esempio, un modello.
Se dunque hai appreso con soddisfazione la fine dell’effetto Bilbao, della spettacolarizzazione dell’architettura e della città, dell’idea che una città possa crescere grazie ai grandi gesti dell’architetto-demiurgo e tuttologo, che si sostituisce non solo alla politica ma addirittura ai cittadini, se tutto questo è vero, come in verità io e tutti gli amici del Gruppo Salìngaros diciamo e scriviamo da tempo, abbastanza snobbati nella forma, ma piuttosto ascoltati, sembra, nella sostanza, se oltre a te molti altri si sono avvicinati, almeno nelle dichiarazioni, a concetti simili, dunque sarebbe bene che, senza snaturare o abiurare il tuo modo di fare l’architetto, anche tu ti accostassi ad una maggiore sobrietà, cioè ad una minore spettacolarità, cominciando ad allontanarti dalla filosofia dell’oggetto per avvicinarti a quella dell’insieme.
Nessuno può chiederti di rinnegare e di abbandonare l’architettura che ti ha reso famoso, nessuno può chiederti, come invece fai te quando ti occupi di politica, di esigere una moralità assoluta e una elitaria virtù da Catone il Censore, che richiederebbe una coerenza tra pensieri, parole ed opere professionalmente suicida. Io almeno, che conosco e tollero e anche apprezzo la fallibilità umana e quell’impasto di fango e spirito di cui tutti noi siamo fatti, non lo chiedo e tantomeno lo esigo da nessuno.
Solo un po’ più di quella che con abusato termine si chiama onestà intellettuale e di sobrietà sarebbe richiesta. Proprio come negli accadimenti che in questi giorni riempiono le pagine dei giornali e di cui non se ne può proprio più, naturalmente da punti di vista diversi.
Con questo auspicio, e direi incoraggiamento, ti saluto e ti invito, se trovi il tempo durante un week-end, a venirmi a trovare in rete, per scoprire magari che potresti trovarvi altri spunti di riflessione e di ripensamento.
Ciao
Pietro
2 febbraio 2011
L'ERESIA DELLA TRADIZIONE
Pietro Pagliardini
“Il termine, fuori dall'ambito religioso, viene utilizzato in senso figurato per indicare un'opinione o una dottrina filosofica, politica, scientifica o persino artistica in disaccordo con quelle generalmente accettate come autorevoli”. Questa è una definizione incollata da Wikipedia. E’ una delle tante possibili, essendo le più riferite all’ambito religioso. Avrei potuto anche utilizzare una di queste ultime, ma avrei corso di rischio di aprire la strada alla facile, ma fuorviante, obiezione di due “dottrine religiose" contrapposte. Ho preferito rimanere nel campo delle scienze umane perché in effetti l’eresia cui mi riferisco si inserisce in un contesto “filosofico,politico, scientifico e persino artistico” in cui sono, sì, presenti anche forme e ingredienti di tipo religioso, con i dogmi (modernità), gli integralismi (fuck the contest), i sacerdoti (Maestri e/o archistar, cioè i nuovi Maestri a livello di massa), gli adepti (praticamente tutti gli architetti) e i tribunali speciali, cioè l’Inquisizione (docenti, metre a penser, commissioni di concorso), ma la verità è più complicata e pervasiva e non è costituita da qualche conventicola segreta (come dimostra il numero degli adepti) ma da ampi settori della cultura ufficiale “generalmente accettata come autorevole” (docenti, metre a penser, commissioni di concorso).
Non c’è dubbio che l’urbanistica e l’architettura che riscopre il valore della tradizione sia trattata al pari di un’eresia. Lo si è visto bene nel caso del piano di Tor Bella Monaca di Léon Krier.
Questi viene chiamato dal Sindaco di Roma, suppongo, per studiare una proposta urbanistica capace di ridare dignità urbana ad un quartiere romano dei primi anni 80, un PEEP, uno dei tanti di quel periodo, sorti in Italia sulla spinta delle nuove leggi, la 865/71 soprattutto e la 457/78.
Due leggi dalla forte impronta ideologica nei confronti del rapporto Stato-cittadini, in cui la proprietà privata viene posta sotto tutela, assoggettata com’è ad una serie di vincoli assurdi e complicati quali convenzioni ventennali per la cessione del bene a prezzi imposti, proprietà indivisa, diritto di superficie ecc. che hanno prodotto, per districarvisi, situazioni di semi-illegalità, come sempre avviene quando le leggi sono assurde, burocratiche e liberticide, le quali tuttavia sono state utili per creare una dipendenza del cittadino-elettore nei confronti del proprio amministratore-eletto, il quale non solo favoriva l’accesso alla casa, con il contributo dello Stato, ma anche favoriva questa o quella cooperativa, questa o quella impresa, anzi, addirittura creava questa o quella impresa o “consorzi di imprese”, e trovava il modo di pilotare i così detti “bandi”, inserendovi criteri ad hoc per questa o quella cooperativa o impresa e perfino rari soggetti singoli, a garanzia formale di una legge liberale.
Il processo edilizio era quindi a circuito chiuso e copriva ogni fase del ciclo, da quello pianificatorio, a quello gestionale, a quello della produzione del bene, imperniato sulla “filosofia” della “industrializzazione edilizia”, a quello politico che ne costituiva la cornice che tutto comprendeva. Un meccanismo perfetto ed oleato, che indubbiamente è stato utile a dare una casa a molti cittadini i quali diversamente avrebbero trovato difficoltà ad averla (in molti casi è più corretto parlare “di un tetto”, in senso metaforico), ma la contropartita è stata la rinuncia ad una quota di libertà, molti compromessi con il diritto e, soprattutto, pessimi risultati per la città e il territorio.
Già, perché il sistema prevedeva anche l’offerta progettuale, la cui dottrina di riferimento accettata come autorevole era quella rigorosamente modernista caratterizzata dalla “industrializzazione edilizia”, esasperata da rigidi parametri dimensionali previsti dalla legge 457/78, il rispetto dei quali produceva automaticamente una tipologia da Existenzminimum, cui per fortuna alcuni comuni più ragionevoli ovviavano con norme interpretative più ampie che allentavano un po’ le rigide maglie ideologico-progettuali. Insomma la matematica, in questo caso la geometria, diventava fortunatamente un’opinione, come i risultati elettorali commentati a caldo; in questi casi l’italico buon senso utilizzava il bizantinismo leguleio, mettendo qualche pezza ai guasti dell’ideologia, perché le leggi basate sull’utopia non possono che produrre quella che viene chiamata illegalità.
Tor Bella Monaca è uno dei prodotti di questo mix cultural-politico: quartieri disegnati al tecnigrafo dove un ordine geometrico astratto regna sovrano, casermoni prefabbricati o semi-prefabbricati che rispettavano, con eccessi di zelo, la regola del calcolo dell’altezza virtuale (che non spiego per carità di patria e che non deve creare sensi di colpa a chi ne ignorasse l’esistenza), edifici senza nessuna relazione con le strade se non per l’ingresso ai parcheggi delle auto (dove si dimostra che l’auto è veramente nemica dell’uomo in periferia più che in centro), enormi spazi aperti secondo il dogma lecorbusieriano, ovviamente deserti in quanto ostili, pericolosi e destinati a rapido degrado e a luoghi del malaffare. Se si confronta questo insediamento con quello più “spontaneo” a ovest, oltre la strada, quest’ultimo appare come un capolavoro da libro di storia.
Ebbene questo quartiere non è recuperabile urbanisticamente per una normale vita sociale. Né giova gridare alla solita mancanza di servizi: i servizi, se ci fossero, darebbero solo un “servizio”, appunto: se in una zona come questa si costruisce una scuola significa che è stato garantito agli abitanti il loro diritto di cittadini e contribuenti di avere una scuola senza doversi sottomettere a lunghi viaggi giornalieri. Dal punto di vista urbanistico e dell’organizzazione dello spazio urbano si è semplicemente rispettato il criterio del Manuale dell’Architetto, CNR, ma la periferia è rimasta periferia e non per questo e diventata città.
Arriviamo dunque al piano di Léon Krier e alla sua eresia.
Il piano è eretico perché demolisce non solo fabbricati ma un’idea, o meglio, un’ideologia, costruita con sapienza nel corso dei decenni, secondo la logica precedentemente spiegata. Demolisce perché non può fare altro, perché quel quartiere non è recuperabile né urbanisticamente né architettonicamente. Demolisce e al suo posto sostituisce un’altra idea, ad essa opposta, la quale tuttavia, a differenza di quella attuale, non è un nuovo esperimento socio-urbanistico ma è presente, da sempre, nel DNA della città europea. Una città di strade e isolati, di piazze e non di spiazzi, di zonizzazione verticale e non orizzontale, di edifici di altezza massima di 3-4 piani e non di casermoni, con una forte densità come è denso il centro storico, e perciò eco-sostenibile, cioè moderna, in quanto, a parità di densità occupa meno territorio.
Non entro nel merito del progetto, cioè nella correttezza delle scelte fatte rispetto al luogo e alle relazioni con l’edificato esistente e con le infrastrutture, perché non conosco il luogo se non fotograficamente. Altri dovrebbero farlo. Purtroppo, salvo rari casi, tra cui un post abbastanza equilibrato sul blog amatelarchitettura, che pure lascia trasparire sotto traccia un certo snobismo per la scelta di Krier, si discute di quel progetto ideologicamente, si ritiene quel progetto un’eresia, una bestemmia gridata contro lo status quo.
Se ne critica, come con il progetto Corviale di Ettore Maria Mazzola, la scelta della demolizione, guarda caso.
Vorrei portare all’attenzione di costoro il seguente comma della legge 865/71, proprio quella di cui parlavo a inizio post:
“Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano”.
Ecco, qui esistono ragioni igienico-sanitarie.
Concludo con questo post tratto da Archiwatch, riferito proprio a Tor Bella Monaca:
Volete Voi una città bella pulita e seducente? …
Oppure una città di merda, piena di monnezza e fatta di oribbili casermoni? …
Inopinatamente … pare … che in molti …
abbiano optato per la prima soluzione …
La sinistra … incredula …
La destra … esulta …
Ognuno lo interpreti come vuole, ma c'è del vero.
Leggi tutto...
26 gennaio 2011
SCRIVE UN ARCHITETTO DI BILBAO....
Un architetto di Bilbao, che ringrazio e che preferisce rimanere anonimo, mi ha mandato questa mail sul tema dei post precedenti, che io pubblico volentieri senza traduzione, per ora. Poiché non conosco lo spagnolo e anche se è abbastanza comprensibile e facile da tradurre con l'aiuto di Google, non vorrei tuttavia interpretare male.
Yo he escrito y comentado respecto al efecto Bilbao, en el mismo sentido que usted.
No hay ninguna duda que el "Efecto Bilbao" es pura propaganda para justificar una determinada política.
Esta política consiste en tomar la ciudad como un campo de acción para grandes operaciones inmobiliarias, suprimiendo cualquier crítica mediante el recurso a las estrellas de la arquitectura.
Hoy las "estrellas de la arquitectura" no son, ni representan ninguna vanguardia, ni teórica, ni ideológica, ni ética.
Creo que esto debiera decirse bien alto, porque todavía piensan ellos que si representan la vanguardia.
El efecto Bilbao, es absolutamente mediático. Desgraciadamente se toma como excusa para operaciones oscuras en todas las ciudades del mundo.
Pero Usted, Pietro, tiene razón; en Bilbao se han llevado a cabo operaciones mucho más importantes que el museo, y que son las que han transforemado realmente la ciudad:
- El metro.
- El Palacio de Congresos.
- Los nuevos puentes sobre la Ría.
- La nueva terminal del aeropuerto.
- La regeneración urbana de la periferia.
- La construcción de nuevos barrios.
- La limpieza de edificios.
- La mejora del mobiliario urbano.
- La creación de grandes estacionamientos subterráneos de vehículos.
- La creación de nuevas plazas y espacios públicos.
. La creación de parques.
- Un nuevo alumbrado público de las calles.
Etc.
Pero SOBRE TODO, las dos grandes obras sobre las que los turistas y los periodistas no se percatan:
1.- La ampliación del Puerto. La más grande de las obras llevadas a cabo por las autoridades vascas.
2.- La limpieza de la Ría. Mediante la creación de enormes depuradoras.
Ante estas dos obras, el Museo es una minucia, algo insignificante desde el punto de vista de gasto o inversión.
Las cosas son así.
Ahora bien, el "Efecto Bilbao" sigue utilizandose en todo el mundo, en un sentido negativo.
Y es entonces, cuando si se critica el "Efecto Bilbao", es cuando las autoridades vascas se enfurecen; porque lo interpretan como una crítica a su gestión. Y no es eso.
En resumen, el "Efecto Bilbao" se utiliza de modo muy sectario, pero se ha de decir que si Bilbao suscita interés como ciudad, se debe a toda una pléyade de acciones, como las que he citado arriba.
Reciba un cordial saludo y mis felicitaciones por su espléndido blog.
"Un arquitecto de Bilbao"
Leggi tutto...
25 gennaio 2011
UN CHIARIMENTO SULL'EFFETTO BILBAO
Poichè il post precedente ha provocato due garbate repliche, molto omogenee tra loro, di precisazione che spiegano abbastanza bene la situazione, mi sembra doveroso mostrare il link a questo articolo del sito
Confermo tuttavia il fatto che in Italia "l'effetto Bilbao" è stato ridotto al museo e utilizzato come un grimaldello da una parte della "cultura" urbanistica italiana ed anche dalla politica per favorire operazioni promozionali delle archistar. Fortunatamente per Bilbao non hanno solo il museo ma molto di più e molto più di sostanza. E sono felici e orgogliosi della loro città.
Pietro Pagliardini Leggi tutto...
23 gennaio 2011
L'EFFETTO BILBAO E' FINITO, MA SI SONO DIMENTICATI DI DIRCELO
Giandomenico Amendola, sociologo, ha scritto un libro, Tra Dedalo e Icaro, Laterza, sottotitolo: La nuova domanda di città, 2010. Amendola analizza la città sotto 10 profili diversi e ad ognuno di essi attribuisce un nome come si trattasse di città ognuna diversa dall’altra: La città sostenibile, La città impresa, ecc. Poi è chiaro che, come egli stesso scrive alla fine, le città si sovrappongono e i confini di ognuna si confondono con le altre. E’ un metodo interessante e anche di piacevole lettura che tra l’altro consente di ridurre a relativa semplicità ciò che è invece molto complesso. Non è detto che non comporti forzature interpretative e anche che non si soffermi su suggestoni molto di moda, rischiando perciò di tralasciare altri aspetti che magari non sono adesso in voga, tuttavia io non sono un sociologo e non voglio entrare troppo nel merito.
Scrive Amendola della Città dell’Impresa:
“La creatività da sola non basta: l’obiettivo strategico è l’innovazione di cui la creatività diffusa è condizione necessaria ma non sufficiente. A differenza della semplice creatività, che può apparire anche in maniera fulminante ma può con uguale rapidità declinare e sparire, l’innovazione è caratterizzata da sequenzialità, irreversibilità e cumulabilità in quanto deve non solo avviare ma anche sostenere e radicare i circoli virtuosi dello sviluppo. Gli stessi casi di Glasgow e Bilbao, sin qui ritenuti esempi da manuale di esplosione di creatività urbana, vengono oggi riconsiderati criticamente. Le crepe che si sono aperte nelle loro economie dopo una felice ma breve stagione di crescita stanno mostrando come la creatività di per sé non sia sufficiente se non innesca un processo sequenziale, cumulativo e tendenzialmente irreversibile di innovazioni produttive, organizzative e politiche.
Il problema principale dell’innovazione è che essa deve radicarsi. Mentre, infatti, è abbastanza semplice individuare – quantomeno per grandi approssimazioni – i fattori capaci di attrarre soggetti creativi, è ancora aperta la questione su ciò che sia necessario perché questi talenti si radichino in una città e non la abbandonino al primo vento di crisi. Tra i fattori di radicamento centrali sono i network, che anche se gli attori dei settori più propriamente artistici tendono a disconoscerlo, legano sinergicamente i protagonisti della città creativa sia tra di loro che agli attori del sistema produttivo e politico tanto locale che nazionale. [….]
Nella logica della competizione tra città, un gran peso assume oggi l’architettura e in particolare quella iconica. Uno degli strumenti che gli amministratori ritengono, a ragione o a torto, fondamentale per affermare la propria città sulla scena internazionale è la grande architettura. La vicenda di Bilbao che ha trasformato il proprio panorama urbano facendo ricorso ai maggiori architetti del mondo, da Frank Gehry a Norman Foster, da Santiago Calatrava a Cesar Pelli, ha fatto scuola. Gli star-architects, gli architetti dalla firma prestigiosa e dalla visibilità mondiale, sono diventati ormai ingrediente costante di tutte le politiche di sviluppo delle città ed elemento di forza delle azioni di marketing urbano. Il rischio è che, paradossalmente, lo sforzo che ogni città fa di distinguersi con l’intervento del grande architetto, possa portare a un’omologazione formale della città.
Nello sforzo di piacere e di conquistare il mercato le città corrono il rischio di somigliarsi sempre più ricorrendo agli stessi architetti di grido, organizzando eventi simili, realizzando fronti mare e arredi urbani talmente uguali che i mercanti d’arte li chiamerebbero eufemisticamente multipli. Ciononostante sembra che il gioco valga la candela. Stazioni, aereporti, piazze, waterfront, banche, grandi magazzini: tutto viene ripescato dalla banalità funzionale per diventare icona e immagine. Sulla scena urbana sono apparsi i musei che, dopo un lungo periodo di disattenzione, sono tornati ad avere un ruolo simbolico starrdinario persino maggiore di quello che – in quanto luoghi dove si concentra e diventa visibile la storia culturale e politica della nazione – avevano svolto per un lungo periodo incoronando le città capitali. […]
L’aura del museo si estende fino a coprire e valorizzare qualunque cosa avvenga al suo interno, anche se priva di alcun rapporto con la cultura. There’s no party like a Museum Party titola il supplemento del “New York Times” del 25 settembre 2009. Il riferimento è ai numerosi party, per lo più promozionali, organizzati da corporation e da privati nei locali del Moma e del Guggenheim”.
Ed ecco un piccolo estratto dalla Città dello Spettacolo:
“Non solo la città produce e contiene spettacoli ed eventi ma, l’obiettivo finale, è che essa stessa diventi spettacolo. La città stessa, in definitiva, può essere un evento. Bilbao è evento così come Berlino è evento: perché evento è, recita il dizionario, “qualcosa che accade in un certo punto a un certo momento” e che merita attenzione. E che fa notizia. Vi sono perciò momenti in cui la città stessa può diventare evento come è accaduto per la Berlino della caduta del muro, la Bilbao del Guggenheim, la Glasgow delle politiche culturali, la Barcellona postolimpica, la Napoli del dopo G8. La città diventa evento ma “dopo”, dopo che è terminato l’evento vero e proprio e la città è riuscita – impresa certamente non facile – a metabolizzarne gli effetti e a farli propri”.
Anche da queste poche righe credo risulti chiaramente che il metodo della scomposizione tematica della città produce risultati apprezzabili. Ma veniamo al contenuto.
Intanto c’è la chiara presa d’atto che l’effetto Bilbao ha esaurito la sua “spinta propulsiva”. Cade così un mito, sul quale in verità da tempo è stata messa la sordina e qualche sospetto era venuto, e quei media e quei soggetti interessati che tanto lo hanno decantato e preso come esempio virtuoso da seguire hanno invece taciuto il rovescio della medaglia. Hanno fatto cioè disinformazione. Solo per questo è valsa la pena comprare questo libro, perché l’autore non è soggetto che sembra avere partito preso contro questo sistema e quindi lo si può ritenere del tutto credibile.
Nonostante questo pare che il mito dell’effetto Bilbao in Italia sia ancora forte, dato che sia per l’EXPO 2015 che per il Ponte sullo Stretto ci si affida a nomi altisonanti, quali Daniel Libeskind, che, tra l’altro, in quest’ultimo caso dove c’è da ottemperare ad un inserimento nel contesto ambientale, sembra una scelta doppiamente immotivata. Effetto Bilbao, che non funziona più, o provincialismo di ritorno, che non ha mai funzionato?
Amendola analizza poi un aspetto oggi dominante nel dibattito urbano, non solo nelle aree metropolitane, da cui ha origine, ma ormai esteso a centri medi e piccoli, almeno nelle intenzioni dei loro amministratori: la tentazione di ricorrere al grande creativo, alla firma dell’architettura, è utilizzata come una scorciatoia alla mancanza di creatività, ma direi di “politica”, da parte della “politica”. Ci si affida ad una o più figure esterne alla città, come in verità si è spesso fatto, che però adesso avrebbero quel quid plus costituito dalla fama mondiale indiscussa(?) e indiscutibile(?), non solo per firmare un progetto capace di fare marketing urbano a livello internazionale, ma anche per “trovare” l’idea capace di cambiare in meglio la condizione della città.
Ci si affida dunque all’architetto, o meglio all’archistar, non solo in quanto progettista famoso ma anche perché lo si ritiene capace, con un solo edificio, di trasformare una città mediante un’espressione architettonica ma anche “funzionale” - che in verità spetterebbe alla politica - capace di concentrare sulla città stessa un interesse esteso e di produrre capacità attrattiva e di stimolo per energie nuove e, naturalmente, creative.
La prima domanda da porsi è: come è possibile che una persona, un architetto, venuto da fuori a svolgere un incarico progettuale possa conoscere la realtà sociale, economica, produttiva, culturale di una città con quattro visite pubbliche e risolva tutti i problemi? Evidente che non può essere così, evidente che siamo nel campo della pura immagine e della propaganda.
Altra considerazione: quand’anche l’archistar di turno penetrasse davvero nell’anima e del corpo della città, cosa offre e cosa produce, in genere? Servizi, evidentemente: culturali, sociali, commerciali, dello spettacolo, del benessere, del tempo libero e quant’altro. Questa condizione presuppone una società di qualche tempo fa, forse solo immaginata più che reale, se non per poche limitatissime aree e città, in cui tutti consumano, si divertono e spendono, ma pochi o nessuno produce, se non i servizi che molti dovrebbero consumare. I fatti recenti legati alla FIAT insegnano però altro e cioè che se non c’è lavoro produttivo per molti i soldi da spendere per pochi, a meno che non speriamo che tutte le aziende de-localizzino e il nostro paese possa vivere, non si sa come, sul lavoro degli altri paesi. Non sembra proprio che questo sistema funzioni anzi sembra che sia stato fatto anche per troppo tempo. Il sistema economico basato solo sui servizi e sui consumi senza fine, sul tempo libero, sulla “cultura”, chiamiamola così, a gogò, mi sembra qualcosa di molto simile alla finanza creativa che ha portato alla crisi del 2008: ricchezza finta che genera povertà vera.
Non è possibile che in ogni città, in ogni paese addirittura, si possa pensare di fare un bel “centro” di qualsiasi cosa, sempre frequentato da gente disposta a spendere e che la storia possa durare.
Qui si immagina una città dello spettacolo, degli eventi continui, dell’effimero portato a condizione permanente. Non sono un economista, ma se due più due fa quattro, la città che ne esce non è per tutti, anzi è davvero per pochi privilegiati, ma il sogno di una vita fatta di eventi e novità continue viene alimentato ugualmente. E poi danno la colpa alla televisione che sarebbe cattiva maestra!
Ultima considerazione, facile da comprendere ma niente affatto scontata, e cioè l’omologazione delle città progettate allo stesso modo, con “multipli”, come eufemisticamente li chiama Amendola. In una città che dovrebbe essere caratterizzata dalla convivenza tra diversi, come scrive l’autore in altre parti del testo, e come è tanto allegramente quanto acriticamente decantato dalla vulgata buonista, tutte le città dovrebbero essere invece uguali tra loro piuttosto che rimarcare le proprie differenze, la diversità, la specificità di ciascuna storia e di ciascun contesto geografico.
Il tempo e lo spazio sarebbero omologati come se il primo dovesse fermarsi, non fosse esistito prima e non avesse lasciato segni caratteristici e il secondo, prodotto del primo, dovesse cambiare per confondersi in un amalgama indistinto e terribilmente anonimo, senz’anima e senza caratteri distintivi.
Leggi tutto...
22 gennaio 2011
IL LATO B DI AREZZO
Con elegante stile letterario il prof. Brilli ci ha restituito un’immagine viva e vera del quartiere la Catona. Ha fatto, anzi, molto di più, perché ha colto il tratto essenziale e unico di Arezzo: quello di avere “un davanti e un retro”, un lato A e uno B. Con tono garbatamente allusivo, Brilli assimila la forma della città alla figura umana, descrivendocela come aperta davanti ma chiusa e impenetrabile dietro, ed evocandone lo stupore nelle rare volte che qualcuno riesce a “prenderla alle spalle”. A quale altra città è concessa una simile, carnale, metafora?
La forma a ventaglio di Arezzo, il cui lato nord è segnato dalle mura che marcano il confine tra città e campagna è stata colta anche dai progettisti dei vari piani regolatori. Sia il padano Gregotti che l’americano Calthorpe avevano subìto il fascino e intuito le ragioni geografiche e climatiche della naturale inedificabilità della zona, e che tale condizione si sposava felicemente con l’armoniosa bellezza del duetto tra città e campagna.
E’ una percezione immediata e istintiva che non necessita di difficili ragionamenti per essere dimostrata vera, basta girare la sguardo dalla Fortezza; è l’essenza stessa di Arezzo, orientata a sud, accessibile da est e da ovest, ma chiusa a nord.
Ma nonostante questa evidenza c’è chi giudica quel vuoto a nord una povertà, piuttosto che una ricchezza, e pensa che la città debba essere richiusa “come tutte le altre città”. Eppure proprio questa espressione dovrebbe suscitare il dubbio che sarebbe meglio non perdere l’unicità assoluta di Arezzo. Purtroppo proprio Calthorpe, forse per curare il “rachitismo” del quartiere di cui parla Brilli, ha formalizzato l’edificabilità di parte della zona.
Nel frattempo quel retro, il lato B, veniva violato dalle scale mobili: ciò che prima era eccezione si è fatta regola, e turisti e aretini, su e giù per le scale, provano quotidianamente il fascino della trasgressione, banalizzandolo e unendo ciò che prima era diviso. Abbiamo perduto “il piacere di penetrare in una città da un ingresso inconsueto”.
E’ difficile non pensare che proprio le scale, che ci hanno assuefatto a “prendere la città alle spalle”, diventino il grimaldello per poter affermare che è maturo il tempo di espandersi a nord, di trasformare una città a ventaglio in una città radiocentrica, di cancellare il lato B, ormai privo di segreti, e di omogeneizzare sapori forti in un amalgama insipido.
Se dopo secoli di storia quella parte di Arezzo è rimasta campagna, non sarà certo perché i nostri avi non sapessero costruire città! Né si penserà, spero, che Arezzo sia stretta in una vallata che non offre più spazio e che rimanga solo quella parte per farla crescere, ammesso ve ne sia bisogno!
Arezzo, nei confronti di mille altre città italiane, è unica per l’insieme, più che per le singole parti; occupare quel retro umido e ombroso sarebbe un intervento di chirurgia estetica irreversibile e l’insieme non sarebbe più lo stesso.
Abbiamo grossolanamente abbattuto le mura urbane, ma per la nobile causa di aprirsi al progresso, alla modernità, al mondo stesso, ed oggi le rimpiangiamo; però non saprei trovare un solo scopo nobile, o semplicemente utile, per riempire quel vuoto a nord.
Pietro Pagliardini
Articolo pubblicato su La Nazione, cronaca di Arezzo
Leggi tutto...
16 gennaio 2011
UN'ALTRA LUMINARIA
E' uno spettacolo di luci sulla facciata della sede e io la mostro come spot pubblicitario ad Arezzo. Leggi tutto...
10 gennaio 2011
IL NON-LUOGO PERFETTO
Un articolo sulla cronaca locale de La Nazione, scritto da Salvatore Mannino, a commento di un progetto di massima per una grande e importante area di Arezzo redatto dallo studio 5+1AA, mi suggerisce una riflessione sul rapporto tra l’uomo, la città e l’auto, e sulla ormai crescente tendenza a cacciarla sotto terra, sotto forma di parcheggi e di strada.
In sostanza, la principale viabilità di accesso alla città, il raccordo autostradale che penetra diritto verso il centro e che è adiacente all’area oggetto del progetto, è stata prevista completamente interrata allo scopo, assolutamente condivisibile, di ricostituire una continuità tra questa e l’area adiacente. Si tratta di un lungo tratto di qualche centinaio di metri, non di un sottopasso; dunque una scelta importante, sia sotto il profilo tecnico che economico. Ugualmente, nell’area progettata, gran parte delle circolazione e dei parcheggi sono previsti interrati.
Scrive Mannino:
“Si tratta di una soluzione assolutamente innovativa, almeno per l’Italia…..All’estero, invece, è uno scenario sul quale si lavora da un pezzo.
A Madrid, ad esempio, è già in programma l’interramento di decine di chilometri delle tangenziali che lambiscono la capitale e delle direttrici che penetrano verso il centro. Alla luce del sole resta solo il prato dei parchi, il traffico viene ingoiato dalle viscere della terra, quasi fossemo nel ventre della città caro a Zola, quasi le auto fossero un oggetto un po’ osceno da nascondere il più possibile alla vista….I parcheggi, dunque, sono sotteranei sia quelli a servizio del triangolo del commerciale che quelli a disposizione delle torri del direzionale e residenziale, le strade asfaltate ridotte al minimo indispensabile, in favore di una rete molto estesa di piste ciclabili….”.
Una scelta, a prima vista, a favore della natura, della città e della salute mentale e fisica dell’uomo: liberarci dalla vista e dall’inquinamento prodotto dall’infame scatoletta meccanica protagonista assoluta degli ultimi cent’anni della nostra storia.
Liberarci da tutto, ma non dalla sua presenza, dato che tutto quanto oggi accade sopra, domani verrebbe semplicemente traslato sotto.
Astraiamoci dallo specifico progetto aretino e immaginiamo di estendere questa filosofia alla generalità dei casi di nuovi insediamenti e alla ristrutturazione urbana delle nostre città.
A questo proposito viene utile citare un articolo di Vilma Torselli su Artonweb, Anche l’urbanistica non è più quella di una volta:
“…..La metropolitana è il mezzo d’elezione di cui tutte le grandi città cercano di dotarsi per gli indubbi vantaggi legati ad una viabilità interrata rispetto ad una di superficie, ed è proprio la metropolitana che ha cambiato radicalmente quello che si potrebbe chiamare il ‘senso del viaggio’.
Perché il viaggio non si svolge più nello spazio, ma nel tempo, tanto che si comincia da più parti a parlare di progetto urbano time oriented.
"La città del futuro nella quale già viviamo [.......] - scrive Sandra Bonfiglioli (Convegno 'Il senso del tempo', Torino 20-21 novembre 2006) - è una città del tempo. [.....] I luoghi per eccellenza della città del tempo sono gli spazi della mobilità: i percorsi "viari" [......]
Il panorama urbano non esiste più, il percorso è un alternarsi di buio e lampi che non forniscono alcuna informazione sulla direzione, il tracciato, i luoghi, un viaggio cieco che termina con l’emersione alla luce in uno spazio urbano raggiunto senza sapere come. La maggior parte della gente percorre in metrò ogni giorno lo stesso tragitto, quasi sempre il percorso casa/lavoro (ma anche /centro commerciale, /università, /scuola, /ospedale ecc.), ignorando del tutto quale parte di città ha attraversato: niente sfilata di palazzi, di facciate note, di vetrine, piazze ed attraversamenti conosciuti, incontri, lo spostamento si concentra in un inizio ed una fine, in mezzo il buio delle gallerie e un tempo marginale ed improduttivo che deve essere il più breve possibile.
Il luogo di imbarco e quello di sbarco, il più possibile vicini alla destinazione in modo da ottimizzare l'abbattimento dei tempi di spostamento, rappresentano l’unico scenario urbano con cui si viene in contatto.
Brandelli di città fine a sé stessi, i luoghi sono riconoscibili per “quel” monumento o palazzo, indifferenziati “oggetti urbani” di grande impatto ambientale che fungono da cronotopi, sorta di matrici spazio-temporali in grado di generare e caratterizzare la dinamica della città e della sua “narrazione” (parafrasando Bachtin).
In questo quadro generale acquistano senso e giustificazione gli interventi delle tanto discusse archistar e la loro architettura autoreferenziale e decontestuale, portatrice di un messaggio personale frutto di un soliloquio che non cerca né confronto né dialogo. Perché l’abitante metropolitano la percepisce nello stesso modo segmentario e parziale con il quale essa viene concepita e calata nel territorio urbano, secondo un processo di interazione nel quale il fruitore chiede solo che quello spazio urbano sia riconoscibile ai fini dell’orientamento spazio-temporale.
Cosicché la presenza di un grattacielo storto piuttosto che di un museo/wc o di un’inaspettata installazione policroma, segni forti non necessariamente comprensibili, ma assolutamente caratterizzanti, possono determinare per ognuno una diversa strategia di “immaginabilità urbana”, in relazione alla individualità dell’esperienza….”.
Basta sostituire “metropolitana” con “rete stradale sotterranea” e il contenuto dell’articolo è perfettamente riferibile al caso nostro, con conseguenze, però, elevate all’ennesima potenza. E con una differenza sostanziale: la metropolitana viene vissuta come infrastruttura puramente tecnica e svolge una funzione prettamente collettiva, ed ha, a suo modo, una motivazione, una spinta etica accanto a quella utilitaristica, riassumibile in questa frase: “diminuisco il traffico in superficie, spendo meno e arrivo anche prima”. La metropolitana diventa una scelta corretta e utile, anche se non particolarmente gradita e amata.
Ma l’auto non è un mezzo collettivo, è il mezzo privato per eccellenza, è il moderno simbolo della libertà individuale di movimento. Relegarla al piano di sotto significa relegarvi chi la guida, cioè la generalità degli individui.
Significa fare una città parallela ma diversa da quella di sopra, anche se ad essa funzionale.
Significa, come scrive Mannino, che: “le macchine sono come il sesso per gli inglesi, qualcosa che c’è ma di cui non si parla (e non si guarda per decenza)”.
L’auto resta dunque e crea due città fasulle: quella di sotto, buia, pericolosa e irrespirabile, quella di sopra, luminosa e verde nell’immagine, ma morta nella sostanza, priva di vita perché la sua vita si svolge sotto, dove la gente trascorre una buona parte del proprio tempo per spostarsi, per recarsi al lavoro o al supermercato o a casa, o all’università o alla multisala.
I movimenti dei cittadini si svolgeranno tutti in ambiente artificiale e andare all’aria aperta sarà un’altra, non prevista, funzione aggiunta a quelle teorizzate da Le Corbusier e imposte dal sistema della produzione di massa. La zonizzazione non sarà dunque solo orizzontale ma anche verticale, ma non nel senso virtuoso del termine, cioè della stratificazione delle funzioni sui singoli edifici che determinano la vitalità della strada e della città europea, bensì estesa a tutta la città.
Il sogno di una città senz’auto si trasforma nell’incubo di una città senza persone perché a questo punto è chiaro che ha, e sempre di più avrà, ragione Vilma Torselli quando afferma che gli oggetti decontestualizzati progettati dagli, o in stile, archistar meglio si prestano a diventare il segno forte e riconoscibile da trovare quando si riemerge in superficie! Che senso avrebbe, infatti, una città costituita da sequenze urbane, da muri pieni e da spazi vuoti che si susseguono e si articolano in un tessuto continuo se tutto il sistema circolatorio, quello che conta e che fornisce la vita e il movimento, si trova in un piano diverso e in un non-luogo oscuro e malsano?
La città diventa un’imitazione degli outlet che imitano, a loro volta, il villaggio tradizionale e il sopra sarà dunque indifferente alla forma, al disegno, all’aggregarsi di spazi e funzioni; potrà avere qualsiasi forma essendo questa solo uno scenario senza vita o con una vita pianificata a intervalli. La città sarebbe schizofrenica e presenterebbe aspetti della personalità completamente diversi.
Non potrebbe più esserci, a questo punto, nessuno stimolo a riaggregare la città in un organismo vitale in cui ogni parte collabori con le altre, perché sarebbe come un corpo umano funzionante grazie alla circolazione extra-corporea, cioè alimentato da macchine.
Se la spinta iniziale di questa scelta è di tipo ecologico e ambientalista, i risultati la negherebbero del tutto perché una metà della città sarebbe completamente dipendente dall’energia, sia di giorno che di notte e l’inquinamento delle auto, che conserverebbe intatto il suo valore assoluto, sarebbe solo concentrato in determinati nodi.
Ho certamente estremizzano un concetto ma se la tendenza fosse questa la fine sarebbe segnata.
La sfida è invece quella di fare convivere civilmente l’uomo con le sue auto o con qualunque altra delle diavolerie che eventualmente le sostituiranno. La sfida è quella di fare una città vitale alla luce del giorno che sia capace di tenere insieme i vantaggi della modernità con quelli della forma tradizionale.
Concludo con un brano ancora da un articolo di Vilma Torselli, La fine dei luoghi:
“Ora, entrata in crisi l’idea di città come luogo rappresentativo di un ordine territoriale specchio di un ordine sociale, assistiamo al diffondersi di una sostanziale equivalenza di stili e di luoghi perfettamente intercambiabili, nei quali emerge l'uso funzionale ed efficientista del modello di città meglio rispondente alle esigenze di mobilità, libertà e flessibilità, unici valori riconosciuti da una cultura eminentemente tecnicista e a-finalistica, che si limita a rappresentare il presente, senza prospettive sul futuro e senza finalità alcuna”.
Chiaro, no?
Per vedere e leggere qualcosa di piacevole sulle città sotterranee seguire questo link:
http://www.fabiofeminofantascience.org/RETROFUTURE/RETROFUTURE12.html
Da questo sito è tratta la foto all'inizio
Leggi tutto...
9 gennaio 2011
INTERVISTA A JULIUS CESAR PEREZ
Julio César Pérez: "La città deve essere sognata, progettata e concepita per il futuro" Intervista apparsa in due parti in Cuban Art News, il 6 gennaio 2011. Il mese scorso, il 16 dicembre, l'architetto e urbanista cubano Julio César Pérez (nata a San Antonio, 1957) ha aperto una mostra di architettura e pianificazione presso la Eduardo Abela Provincial Gallery, nella città di San Antonio de los Baños.
Pérez, che si è laureato alla scuola di architettura dell'Avana nel 1982, ha insegnato e tenuto conferenze presso la Harvard University, il Boston Architectural Center, e l'Università di Toronto. E 'autore di Inside Cuba (Taschen, 2006), L'isola: Visioni di Cuba (Editoriale Samper, 2009).
Altre notizie su Pérez sono reperibili qui.
La versione originale in lingua inglese dell’intervista è consultabile qui.
Davvero non ricordo nessun mostra collettiva di architettura, ad eccezione di quelle fatte dagli allora giovani laureati degli anni '80 - ed io stesso tra loro, nel 1987 (presso il Centro di sviluppo per le Arti Visive, e nel 1991 (a La Cabaña).
La mia ultima mostra personale ha avuto luogo nel 2002 presso la School of Design alla Harvard University . Lì, ho presentato una selezione di 20 opere e progetti realizzati tra il 1989 e il 1999. In precedenza, con gli architetti Céspedes Milvia e Esteban Martinez, ho fatto una mostra a San Antonio de los Baños durante la 6° Biennale de L'Avana nel 1997. In tutti i casi, l'intenzione era di mantenere in vita l'architettura come una vocazione, e di proiettare una visione di questa professione che continua la tradizione e il savoir faire che ha caratterizzato la sua pratica nel nostro paese nel corso degli ultimi quattro secoli.
Adesso mi ha spinto di nuovo questa necessità. E'utile anche per analizzare un periodo di lavoro, per confrontarsi con idee e approcci e, soprattutto, per dimostrare che l'architettura rimane una delle belle arti, se ci si avvicina ad essa con una prospettiva artistica rigorosa.
La vostra mostra copre una vasta gamma di argomenti: residenze personali, paesaggi urbani, ristrutturazione di edifici storici, pianificazione urbana. Corrispondono ad una vasta gamma di interessi in architettura?
Per me, la pratica dell'architettura inizia con il rapporto tra l'ambiente naturale e quello culturale, che è un tutto indivisibile, e l'essere umano. La città è l'elemento più importante, in quanto è espressione di rapporti umani e l'archetipo culturale essenziale. I miei interessi sono ampi, e io rinuncio alla visione riduzionista e alla specializzazione che hanno fatto molto male a questa professione in tutto il mondo. L'architetto deve sempre essere un uomo del Rinascimento che agisce in modo responsabile nel suo tempo; egli deve fare i conti sia con gli eterni problemi che con i conflitti contemporanei derivanti dalla sua situazione concreta. Questo richiede uno studio costante, soprattutto per coloro che si dedicano all'insegnamento.
Quando si avvicina alla casa - un tema "tradizionale" e un laboratorio per gli architetti cubani - sembra che lei usi tecniche di costruzione e competenze già ben consolidate nel repertorio popolare.
La casa è il punto di partenza, il soggetto più vicino agli esseri umani, per l'architetto. Io credo che gli studenti dovrebbero imparare a progettare una casa prima di ogni altra cosa. Molti giovani architetti non si sa come, e questo è deplorevole, non hanno nemmeno un'idea precisa di quello che sia una casa, di che cosa sia la loro casa. E' un esercizio di buon insegnamento. La scala consente di iniziare da un'idea generale e di passare ai dettagli, di partire da una situazione specifica in termini di localizzazione, relazioni spaziali, requisiti funzionali, programma, contesto, scopo, per poi arrivare ai dettagli.
Si tratta di un processo che permette l'apprendimento. E'indispensabile per progettare bene, per costruire bene - si tratta di una lezione antica e tuttora valida. La tradizione fornisce le istruzioni necessarie da cui gli architetti possono esplorare e innovare, e trovare la propria lingua oltre la moda e le tendenze.
D'altra parte, a Cuba non ci sono molte opzioni per quanto riguarda l'utilizzo di tecniche di costruzione non tradizionali e materiali - soprattutto nelle abitazioni. Il fallimento totale e ripetuto della prefabbricazione è stato il fattore più eloquente a favore di un ritorno alle tecniche di costruzione tradizionali. La perdita di questo lavoro (progettare case) è, inoltre, uno dei fattori che hanno intaccato il prestigio della professione. Questo è triste, dato che l'industria delle costruzioni in questo Paese è stata caratterizzata da un alto livello di abilità, che ha raggiunto il suo apice nel corso del 1950. Ho imparato il rigore, la disciplina, e il mestiere del lavoro con mio padre, un eccellente muratore e capomastro.
Nel vostro piano per la crescita e la sviluppo futuro dell'Avana, quali giudichi che siano gli elementi chiave?
Il piano è basato su un decalogo, un programma in dieci punti che riassume una serie di idee interconnesse e integrate. Tutti i punti devono essere considerati insieme, sulla base della loro ovvia relazione e la necessità di affrontarli tutti con la massima economia di tempo e risorse.
1. Valorizzazione del Waterfront. Questo darà alla città una nuova immagine e ci permetterà di cogliere il maggior vantaggio del suo litorale. Sono previsti edifici ad uso misto: usi culturali e commerciali al piano terra e l'uso residenziale ai piani superiori. Ciò stabilisce una continuità con le tradizioni della città e offre un modello in linea con le tradizioni europee basandosi su caffè all'aperto, gallerie d'arte e ristoranti, bar, negozi e bazar. D'altra parte, c'è il settore del porto di L'Avana, la cui rigenerazione è un modello per l'intera città. Abbiamo intenzione di trasformare questa zona in un moderno centro commerciale e sportivo che contribuirà ad una nuova immagine della città e consentira la ri-creazione della sua storia, il riciclaggio delle sue funzioni economiche, ed aumenterà l'attrattiva della capitale in generale.
2. Un Approccio Maggiormente Policentrico. Questo è essenziale. Esso comprende la creazione di nuovi centri urbani nella proposta di sviluppo di impianti a ovest (sito del vecchio campo d'aviazione Columbia) e ad est. Questo approccio riduce l'espansione della città verso le sue periferie, limitando la necessità di eccessivo traffico e di viaggio.
3. Un Nuovo Sistema di Trasporto Pubblico. Ciò permetterà un uso efficiente e razionale delle infrastrutture stradali esistenti e proposte, e permette di disporre di vari e moderni mezzi di trasporto (treno, autobus, automobili) che non inquinano l'ambiente. Il piano prevede il trasporto di superficie e sotterraneo, e uno dei suoi rami prevede la costruzione di un tunnel parallelo alla linea di costa, che creerà una "promenade" lungo la costa da Jaimanitas a Cojimar.
4. Rinnovamento delle Infrastrutture. Attualmente, le infrastruttura della città sono obsolete, del tutto inadeguate e insufficienti. Questo rinnovamento migliorerà l'Avana e amplierà i servizi dell'acqua, dell'elettricità, delle fognature, del telefono, di internet ad alta velocità, e di altri servizi. E' pianificato un incremento dello spazio pubblico per rispondere alle idiosincrasie di Cuba, dei suoi costumi e delle sue tradizioni. Nella zona costiera e nella baia sarà istituita una zona cuscinetto che conterrà un possibile aumento del livello del mare dovute ai cambiamenti climatici derivanti dal riscaldamento globale.
5. Integrazione Sociale e Culturale. Il punto di arrivo di un pieno utilizzo della città, dei suoi quartieri e dei suoi spazi da parte di tutte le persone, con libero accesso a tutte le strutture ed edifici.
6. Sicurezza Ambientale e Aumento delle Aree Verdi.
7. Una Nuova Immagine della Città. Con questo si intende trasformazione della città e vitalità come risultato di azioni urbane e civili.
8. La Rivitalizzazione delle Strade e delle Altre Vie a Livello Cittadino.
9. Uso misto. Questo è parte della tradizione della città. Esso prevede la vitalità e la varietà necessaria per la vita urbana, combinando varie funzioni che indirizzino i diversi gruppi sociali.
10. Una Visione Ampia Combinata con un Dettagliato Disegno Urbano. La città deve essere sognata, progettata e concepita per un futuro che trascenda il segno di un'epoca particolare, e la cui costruzione sia la risultante degli sforzi e dell'intervento di diverse generazioni. Il piano urbanistico dovrà proporre progetti di diversa scala che potrebbero essere costruiti in diversi momenti nel tempo, e la cui flessibilità accetta le trasformazioni richieste dalle circostanze.
Che cosa rende questo progetto diverso dagli altri che l'hanno preceduto?
Proponiamo una visione olistica e integrata. I piani precedenti non ha considerato l'Avana per quello che è: un insieme, un territorio con un ecosistema particolare che deriva dalla sua condizione geografica, dalle sue idiosincrasi e dalla sua cultura. Per la prima volta nella storia, e questo è forse il suo più grande merito, questo Master Plan inventa e sviluppa idee per trasformare la capitale nel breve, medio e lungo termine, e di trasformarlo in una città moderna che fa onore alla sua lunga storia ed esprime il suo continuo processo di cambiamento. A differenza dei piani delineati nel periodo coloniale, che erano di natura militare, quelli della Repubblica, che sono stati frammentati e limitati solo ad alcune zone, e quelle formulate dal Dipartimento di Urbanistica durante il periodo rivoluzionario, che sono stati dettati dal governo e dale sue priorità, il Piano per L'Avana del 21° secolo cerca di preservare i valori della città esistente pur sottolineando la necessità di creare nuovi valori economici e urbani.
Inoltre, questo piano non segue alcun dettame o ordine governativo. Si tratta di un lavoro di amore per la città, fatto senza compenso. E' un dono, un contributo personale.
Come si caratterizza lo stato attuale dell'architettura a Cuba? Dove si trovano le sue principali contraddizioni?
Lo stato attuale dell'architettura è pietoso. Nessuna attenzione viene data alla qualità dei progetti o di ciò che è costruito, il che si traduce in un grande spreco: di terre, di risorse, di talenti e di tempo. Questo dimostra l'ignoranza e l'apatia. Non esiste un sistema di valori che differenzia l'architettura dalla costruzione semplice. Le contraddizioni iniziano nelle scuole: gli insegnanti non hanno l'indispensabile prestigio e l'autorità professionale, in quanto non hanno organi del lavoro che convalidino le loro carriere. L'insegnante dovrebbe essere un esempio. Quando l'insegnamento è necessario per conoscere e imparare, per avere un esperienza di lavoro, una solida cultura. Per questo motivo, un neolaureato non può insegnare, poiché non hanno alcuna esperienza professionale e nessuna capacità di insegnamento. Questo è un grave errore.
La mancanza di una guida, con comprovate credenziali e una solida reputazione basata su meriti accademici e professionali - essenziali per occupare posizioni di leadership nella scuola e reparti livelli - ha contribuito alla formazione inadeguata di diverse generazioni di architetti.
La professione dell'architetto richiede sacrificio e dedizione al di là del necessario e l'indispensabile chiamata o il senso della vocazione. La successiva motivazione è parte del compito dei docenti la cui condotta e il cui lavoro dovrebbe servire da modello per i futuri architetti. Un altro fattore è la mancanza di una pratica professionale che contribuisce ad una graduale, progressiva formazione, che insegna a correggere gli errori.
Un altro elemento è l'assimilazione acritica di progetti stranieri e il rifiuto di architetti cubani a favore di professionisti stranieri di dubbia reputazione. Il processo di investimento è pieno di opinioni negative e di grande corruzione. Ciò ha contribuito alla perdita di autorità e di prestigio degli architetti locali, abbandonati da istituzioni create per garantire i loro interessi, e una perdita di autostima e di dignità personale e professionale.
L'assegnazione dei progetti e dei posti di lavoro a soggetti stranieri senza gara formale non comporta solo costi eccessivi, ma favorisce i pericoli ideologici della globalizzazione, che ignora la cultura, la storia e la stessa professione. Altri modelli e schemi sono già stati implementati.
Gli esempi abbondano, tutti negativi. Si va dagli hotel costruiti dalla catena alberghiera spagnola Meliá (L'Avana, Cohiba, Varadero) a quelli fatti per altre catene alberghiere: Novotel o LTC a Monte Barreto, per il Gran Dutch Tulip (Central Park), le costruzioni immobiliari (per gli investitori a Monaco), al 5° Avenue, o quelli costruiti a Monte Barreto (come il Miramar Trade Center). In questa zona, l'ignoranza del disegno urbano tradizionale sembra essere stato raccolta e sintetizzata, incapace di assimilare o i valori del contesto, naturale e costruito, o l'uso misto. Questi progetti falliscono perfino nel corretto orientamento degli edifici e delle loro relazioni spaziali, portando alla svalutazione di una delle poche aree verdi a L'Avana.
Sul piano della pura architettura, gli edifici mancano della qualità di base del progetto e dimostrano la mancanza di padronanza della scala e dell'uso dei materiali. Sembra che gli alberghi abbiano istituito un concorso a premi per emulare il peggior edificio costruito dai loro predecessori. Tra loro ci sono l'ambasciata Russa e disfunzionali hotel Tritone e Nettuno.
Insieme ai vostri progetti, voi conducete anche workshop intensivi con studenti di architettura. Qual è la sfida più grande: la creazione di una "scuola intorno a un insegnante" o intorno alla realtà concreta?
Entrambe le cose. Preferisco descrivere un'esperienza nel processo di creazione della Scuola Nazionale di Pianificazione e Architettura, che ha scommesso sulla città, i suoi monumenti, ma anche sui suoi edifici sensibili integrati nell'ambiente circostante. A L'Avana, ci sono molti esempi di tutte le epoche, che vanno dal Castello di Morro, dove lo scoglio e l'edificio si fondono armoniosamente, ai palazzi del tardo 18° secolo - un'architettura urbana di straordinario valore.
I seminari già accennati come pure L'Avana Charette uniscono, incoraggiano, propongono ed esprimono la volontà di invitare tutti senza escludere nessuno. Essi cercano di instaurare una tradizione (e ci sono stati quattro workshop consecutivi) di consultazione: per mostrare quanto è stato fatto, senza pregiudizi. La cosa importante è trasmettere agli studenti l'amore per la città e i suoi dintorni, oltre che una responsabilità verso essa e il suo futuro, se vogliamo rimanere a L'Avana, la città magica, poetica e magnetica che cattura tutti con il suo fascino, illumina il cammino con la sua progettazione, e ispira con la sua architettura. La realtà impone sfide, ma dobbiamo distinguere le sfide temporanee e dettate dalle circostanze e temporanee da quelle reali, veramente critiche.
Credi in una architettura d’"autore" - nota negli Stati Uniti come "starchitecture"?
L'architettura d'"autore" è un inganno, un'architettura orientata verso l'oggetto, non verso la città. Generalmente, le opere create da architetti che sono famosi per essere iconoclasti non resistono al tempo. O molto poche sopravvivono al passare del tempo o alla giudiziosa, obiettiva critica quando sono analizzate nel loro contesto e non in riviste e libri gestiti da fotografi qualificati.
Il fatto è che solo un piccolo gruppo di architetti sopravvive alla critica obiettiva, e questo è vero ovunque. Penso che tra loro ci sono Frank Lloyd Wright e Louis Kahn, di quelli del passato. Tra quelli attuali c'è Renzo Piano, il cui rigore nella progettazione e costruzione supera il resto. E forse il giapponese Tadao Ando. C'è un sacco di spazzatura costruita in nome della "architettura dell'autore."
Il più grande problema causato da questo modo di fare è il danno alla mentalità e alla formazione di studenti, perché introduce modelli di imitazione favorita da insegnanti ignoranti, che sono privi di cultura visiva e in grado di sviluppare il proprio personale lavoro. La maturità di un architetto, io credo, è quella di imparare in modo che il loro lavoro non sia appesantito dall'architettura di "un altro autore". E' la più grande sfida e una grande prova di onestà intellettuale.
Recentemente, hai avuto un percorso lungo e intenso come docente di scuole e università americani. Come descriveresti l'approccio degli Stati Uniti nei confronti del patrimonio architettonico di Cuba e delle sue trasformazioni future?
C'è grande ammirazione e grande apprezzamento per il patrimonio architettonico di Cuba e dei valori di L'Avana. Un grande rispetto. Mi sento molto orgoglioso, molto felice quando parlo di L'Avana, la sua architettura, la sua urbanistica, che è intatta fino ad ora, nonostante tali edifici perduti. Ecco perché è così importante conservare la città al di là di qualsiasi edificio o gruppo di edifici.
La gente mi incoraggia nel mio lavoro. Essa lo riconosce. Parlo di L'Avana con amore e grande ammirazione. Tutti vogliono vedere L'Avana, vogliono venire a L'Avana. Coloro che sono stati qui vogliono tornare. Questo deriva anche dal fatto che la nostra nazione è più vecchia, ha le sue radici europee, e ricordiamo che le città di Cuba sono state fondate dagli europei - che è senza dubbio di enorme valore. La pianificazione urbana spagnola era di qualità elevata e questo, combinato con il necessario adattamento al nostro clima, la nostra geografia, e altre caratteristiche (come la disponibilità dei materiali) ha prodotto un'architettura vernacolare di grande valore. Nella sua essenza, "vernacolare" significa creatori anonimi - l'antitesi del concetto di "architettura d'autore".
Inoltre in Nord America ci sono solo poche città storiche, e la gente riconosce i valori storici che sono custoditi a L'Avana, insieme con i valori architettonici e urbanistici. Molti professionisti dell'architettura, e la gente in generale, hanno espresso la loro preoccupazione per la futura evoluzione della città, attraverso l'emergere della sensibilità del mercato e la possibilità di perdere L'Avana, cambiando la sua immagine seducente e romantica. Quando ne parlo dico sempre che questo è il concetto del Master Plan per il 21 ° secolo all'Avana.
Leggi tutto...
6 gennaio 2011
STRADE- 11°: RAYMOND UNWIN
Post dedicato a Raymond Unwin con LA PRATICA DELLA PROGETTAZIONE URBANA, Il Saggiatore, 1995, libro ormai fuori catalogo.
RAYMOND UNWIN
La pratica della progettazione urbana
Il Saggiatore, 1995
4- Indagine sulla città
Il primo compito del progettista, quindi, deve essere quello di studiare la sua città, l’ambiente, la gente e le loro necessità. Non c’è da temere che questa linea di condotta porti a progetti banali, che freni i voli della fantasia e subordini gli effetti principali alla futile convenienza. La fantasia di colui che riesce a creare soltanto quando la mente è libera da condizioni, ha probabilmente poco valore, mentre l’opera di chi, pur mancando di slanci geniali, è in grado di comprendere e provvedere alle necessità del caso, è almeno prudente e utile. In questo campo non possiamo dire che le considerazioni pratiche precedono quelle artistiche, o che le artistiche precedono quelle pratiche: sono entrambi interdipendenti e devono essere valutate insieme. Vi è tuttavia questa differenza, e cioè che le considerazioni pratiche sono ben precise, mentre l’espressione artistica può prendere forme varie. Le fognature non possono scorrere verso l’alto per adeguarsi al più splendido dei piani; né la gente, per assecondare il più imperioso dei progettisti, andrà dove non ha voglia di andare, o si asterrà dall’andare dove ha necessità di andare, e dal prendere la via più breve per arrivare in un dato luogo. Le fognature e le direttrici del traffico possono subire modificazioni, ma soltanto entro limiti molto ridotti; e l’urbanista che pone il suo piano contro le forze che definiscono questi limiti, farà soltanto naufragare il progetto…..
7-Della organizzazione, della sistemazione e della disposizione del verde nelle strade principali
…Le strade tuttavia non sono soltanto strutture per il traffico, ma assolvono anche la funzione secondaria di delimitare e fornire aree edificabili, e non sempre accade che il tipo di strada o di incrocio più conveniente per il traffico offra necessariamente le migliori aree edificabili, o permetta la migliore disposizione degli edifici; in alcuni casi sarà quindi necessario fare alcune concessioni in un senso o nell’altro, e a volte sacrificando la bellezza degli edifici a favore del traffico, e a volte sacrificando in parte la continuità del flusso del traffico a favore di una migliore disposizione degli edifici.
L’aspetto pittoresco delle vecchie città gotiche è dovuto in buona parte alla dimensione ridotta delle sezioni stradali. Queste dimensioni non soltanto definiscono e danno un senso di completezza alle prospettive stradali, ma è molto più facile, con queste strette strade, creare un effetto di spazio circoscritto nella place in cui confluiscono. Se le strade sono ampie e fiancheggiate da piccoli edifici, è facile che la loro caratterizzazione vada completamente perduta, poiché il rapporto fra i due lati della strada non può essere colto con esattezza, e per ottenere risultati positivi può darsi che si debba ricorrere a tutt’altro tipo di effetti. Sembra che non vi siano ragioni per non prevedere anche nelle città moderne un certo numero di strade più strette e di passaggi che diano accesso a edifici le cui caratteristiche non richiedono una vasta superficie libera.
Abbiamo visto parlando delle places e delle piazze quale importanza hanno ai fini dell’effetto generale la definizione dello spazio e la continuità degli edifici che racchiudono questo spazio e il discorso è valido anche per le strade. Considerando perciò gli edifici come un mezzo per garantire una sufficiente continuità della scena stradale, sentiremo la necessità di chiudere di tanto in tanto la prospettiva; questo risultato si potrà raggiungere mediante una interruzione del tracciato, o un cambiamento di direzione, o una curva, espedienti che mettono in risalto alla fine della strada alcuni fra gli edifici posti sul lato concavo…..
8- Del “site planning” e delle strade residenziali
Nel site planning uno studio accurato del territorio e una indagine sulle quote, con l’indicazione degli alberi esistenti, delle prospettive e di ogni elemento interessante che l’area può offrire sono altrettanto essenziali al fine di ottenere un buon risultato che nel caso del town planning. Troppo sovente i site planners hanno redatto i loro piani soltanto sulla carta, e, per evitare fastidi, hanno eliminato alberi e siepi se questi capitavano sulla loro strada. Non vi è sistema peggiore di questo, poiché una nuova zona residenziale, nel migliore dei casi, avrà un aspetto freddo e povero, i giardini appariranno vuoti o pieni soltanto di miseri arbusti e di povere piante, e, a prima vista, nulla giova maggiormente a un’area edificabile della conservazione degli alberi esistenti e, a volte, anche delle siepi.
Se, per esempio, si fa scorrere una strada parallelamente a una vecchia siepe ben coltivata, immediatamente si assicura alla strada una splendida decorazione e un carattere particolare, mentre i giardini acquistano un senso di privacy, che una siepe appena piantata permetterebbe forse dopo molti anni.
Una delle prima preoccupazioni nel pianificare un’area fabbricabile, sia grande che piccola, dovrebbe essere quella di determinare il centro del progetto. É probabile che in ogni area, a eccezione di quelle piccolissime, siano necessari edifici di uso pubblico di dimensioni maggiori di quelli per abitazione, come, per esempio, chiese, cappelle, sale pubbliche, istituti, biblioteche, bagni, lavatoi, negozi, locande o alberghi, scuole elementari o di altro tipo; una volta previsti gli edifici necessari, ammesso che ve ne siano, sarebbe forse bene concentrarli in una posizione adatta a fare di questi il centro del progetto. Chiese e cappelle devono essere facilmente raggiungibili, in luoghi prominenti e non troppo vicine le une alle altre o a altri edifici destinati ad essere utilizzati la domenica, poiché le funzioni potrebbero essere disturbate dai canti provenienti dalle chiese vicine.
Nel caso di negozi e di luoghi di ristoro e di luoghi di ristoro si pongono necessità diverse; il fatto essenziale è che siano situati sulla strada principale, dove il traffico è, o dovrebbe essere, più intenso. I negozi, inoltre, hanno generalmente maggior successo se sono riuniti in numero sufficiente a formare ciò che i commercianti chiamano un “mercato”; i negozi sparsi non riscuotono molta simpatia. A volte sarebbe meglio limitare i centro ad una parte di un’ampia arteria, che potrebbe comprendere i negozi e alcuni edifici pubblici, come accade nella strada principale dei paesi, dove ognuno si sente di casa. In altri casi sarà possibile riunire i negozi nelle strade principali e contemporaneamente creare di fronte a questi uno spazio verde o una piazza intorno alla quale raggruppare alcuni degli altri edifici. Non vi sono dubbi, tuttavia, qualunque ne sia la forma, circa l’importanza anche nelle piccole aree di un elemento centrale, quale punto di riferimento del progetto.
Nel pianificare un’area a scopo residenziale molto spesso non sarà possibile conseguire effetti architettonici definiti, come sarebbe consigliabile nel pianificare una città; il pianificatore deve fare attenzione a non sacrificare a qualche particolare effetto di suo gradimento la comodità e la felicità di coloro che occuperanno gli edifici, altrimenti, con tutta probabilità, il suo progetto non sarà realizzato.
La bellezza dell’ambiente circostante costituisce indubbiamente uno dei piaceri e delle attrattive maggiori dei quartieri residenziali, e sarà probabilmente economico dedicare molte attenzioni, denaro e spazio alla progettazione di queste aree allo scopo di renderle piacevoli; si devono tuttavia cercare delle forme di bellezza che non contrastino con i forti pregiudizi o i desideri dei futuri abitanti. Ciò spesso porterà a una distribuzione delle case più diffusa di quella desiderabile da un punto di vista puramente architettonico.
Anche qui, tuttavia, raggruppando gli edifici sarà possibile dare loro una vista più ampia e un senso di apertura più generale di quanto sarebbe stato possibile se gli stessi fossero maggiormente distanziati, e sarà anche facile convincere coloro che desiderano una casa unifamiliare circondata da un pezzo di terra a occuparne una compresa in un gruppo, se questo sarà organizzato in modo tale da offrire un vantaggio evidente per ciò che riguarda la vista.
Anche nel campo del site planning si pone subito il problema di una organizzazione formale o informale già discusso in relazione al town planning, e buona parte di quei principi sono applicabili anche in questo caso. È probabile che la varietà delle soluzioni possibili per una organizzazione ordinata di edifici e strade residenziali sia molto più ampia di quanto a prima vista potremmo aspettarci.
Il territorio stesso, di solito, fornirà motivi sufficienti a imporre o suggerire la realizzazione di edifici irregolari e di altri elementi accidentali di un certo interesse, che possiamo accogliere di buon occhio, poiché alla loro abile organizzazione sono legati il successo e la bellezza del piano una volta portato a termine. Nel site planning, tuttavia, come in architettura, la ricerca fine a se stessa di elementi caratteristici è facilmente soggetta a generare confusione. È molto più prudente, sia che un piano abbia caratteristiche formali che informali, non fare nulla senza motivi ben precisi. Abbiamo presente l’importanza di certi piccoli spazi aperti, luoghi dove la gente può ripararsi dal trambusto della strada per fermarsi e riposare un momento…..
È importante che il town planning e il site planning impediscano la separazione completa delle diferenti classi sociali, che è una caratteristica notevole delle città inglesi moderne.
La signora Barnett nei suoi scritti ha dato particolare enfasi a questo problema e ha additato i molti mali dovuti al fatto che ampie aree sono interamente abitate da gente appartenente a una unica classe sociale….. Al town planner non è data la facoltà di modificare i pregiudizi della gente, o di impedire l’espandersi dell’ “east end” e del “west end” in una città. Molto tuttavia può essere fatto in questa direzione con accurate previsioni, e certamente non vi è alcuna difficoltà, entro limiti più o meno ampi, a alternare case di diverse dimensioni. I pregiudizi della gente non possono giustificare la costruzione su ampie di case delle stesse dimensioni e dello stesso tipo; l’espansione di sobborghi occupati soltanto da un’unica classe sociale, qualunque essa sia, è negativa sia dal punto di vista sociale che economico e estetico. …..
Nei paesi inglesi troviamo case di ogni tipo che si alternano lungo la strada principale o intorno al verde, dalla più piccola casa dell’operaio alla grande casa del ricco agricoltore, del dottore o dell’industriale locale e, a volte, anche la residenza del signore del luogo. Dalle figure è possibile capire in quale misura questa varietà contribuisca a accrescere il fascino della strada principale del paese……
Post correlati:
STRADE-1°: PALLADIO E JANE JACOBS
STRADE-2°:CHRISTIAN NORBERG-SHULZ
STRADE 3°: RUDOKSKY E MUGNAI
STRADE- 4°: MARCO ROMANO E CAMILLO SITTE
STRADE-5°: ETTORE MARIA MAZZOLA
STRADE – 6°: KEVIN LYNCH
STRADE-7°: FRANCESCO FINOTTO SU KARL HEINRICI
STRADE- 8° : LEON KRIER
STRADE- 9°: DANILO GRIFONI
STRADE 10°: BERNARDO SECCHI
JANE JACOBS
JANE JACOBS: STRADE
UNA LEZIONE DI URBANISTICA
MORE ETHICS OR MORE AESTHETICS?
CITTA' ORGANISMO O CITTà MACCHINA
LA CITTA' DELLE REGOLE
Leggi tutto...